Kenneth Mackenzie (Coinneach Mac Coinnich)
1762, Castle Leathers, Inverness, Scozia — 1819, Fermoy, Cork, Irlanda.
Quando
Rowland Hill Mackenzie assistette al parto della moglie Gertrude che
gli stava donando il primo figlio, oltre a presagire che il suo futuro
professionale sarebbe stato tra ginecologia e ostetricia, gli balenò
altresì alla mente un consistente e vivido ricordo del proprio padre,
che oramai da quattordici anni riposava in pace. Rammaricato che la sua
discendenza non avrebbe mai conosciuto il nonno, Rowland risolse di
tramandarne la memoria attraverso il nome, nel solco della tradizione
scozzese del leitname. Il 4 Maggio 1834, per perpetuare appunto il nome
guida della famiglia alla nuova generazione, nella chiesa di St. Michael
Bassishaw di Londra entro le Mura, l’infante fu battezzato Kenneth
Robert Henderson Mackenzie.
Da notare l’eleganza dell’esercizio onomastico. Il primo nome Kenneth è un semplice avonimico del nonno, mentre le iniziali del secondo e del terzo nome R. H. sono un sobrio richiamo a quelle patronimiche R[owland] H[ill], rendendo così esplicita l’ascendenza genalogica dell’ultimo accolto nel clan. E non poteva essere altrimenti, penso appena scopro che Kenneth MacKenzie, in originale gaelico “Coinneach Mac Coinnich”, è tradotto come “Kenneth figlio di Kenneth”. Sempre che effettivamente anche il bisnonno portasse questo nome.
L’annuncio di matrimonio di Rowland Hill mi dà il primo indizio. Dal Southern Reporter and Cork Commercial Courier di sabato 12 gennaio 1833:
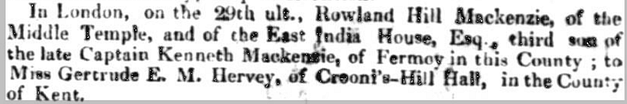
Nonno Kenneth era quindi stato capitano dell’esercito ed era di Fermoy, nella contea di Cork in Irlanda.
Al
che una ricerca <Kenneth Mackenzie> + <Fermoy> mi rimanda
alla figura di Robert Shelton Mackenzie, secondo figlio del capitano di
Fermoy. Quindi fratello di Rowland Hill e zio di Kenneth Robert
Henderson.
Robert Shelton Mackenzie nella seconda metà dell’Ottocento
aveva raggiunto una certa fama in qualità di giornalista e scrittore,
in particolar modo per le biografie di personalità popolari, come quella
di Charles Dickens, che si rivelò il suo maggior successo. Un grado di
notorietà sufficiente a permettermi di trovare sui giornali di allora
numerosi lanci pubblicitari delle sue opere, presentazioni e critiche; e
quasi sempre si faceva cenno alle sue origini gaeliche e al padre,
poeta vernacolare, alludendo quasi a un’ereditarietà del gene
letterario.
Si trova addirittura una voce enciclopedica a lui dedicata, ancora in vita:
Mackenzie nacque a Drews Court, contea di Limerick, il 22 Giugno 1809, secondo figlio del capitano Kenneth Mackenzie, ufficiale dell’esercito e autore di un volume di poesie gaeliche, pubblicato a Glasgow nel 1796. Robert fu educato in una scuola di Fermoy, contea di Cork, dove il padre ricopriva la carica di direttore delle poste dopo essersi ritirato dall’esercito.
The New American Cyclopaedia — Popular Dictionary Of General Knowledge, Vol. 11, a cura di George Ripley e Charles A. Dana, New York; D. Appleton & Company, 1861.
La voce continua citando minuziosamente tutta la sua produzione letteraria, anche la meno significativa, come a legittimare la sua inclusione nell’enciclopedia. Dissimulazione che potrebbe funzionare se non si arriva a leggere, alla fine del Volume 16 della Nuova Enciclopedia Americana, l’ultimo uscito nel 1866, la lista dei contributori, nella quale guarda caso, compare:
R. Shelton Mackenzie, D. C. L., Philadelphia, Penn.
Advertisment, Autograph, William Beckford, George Brummel, Richard Bentley, Bishop Burnet, William Cobbett, &c.
In quel &c., potrei sbagliare, ma secondo me c’è anche la propria biografia, che a questo punto considererei piuttosto un’autobiografia.
La storia si ripete in
Samuel Austin Allibone, A
critical dictionary of English literature, and British and American
authors, living and deceased, from the earliest accounts to the middle
of the nineteenth century. Containing thirty thousand biographies and
literary notices, with forty indexes of subjects. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co., 1870.
Anche qui serve un minimo di approfondimento per scoprire che nella prefazione al suo Sir Walter Scott: The Story of his Life, Robert Shelton Mackenzie chiama in causa il curatore del Dizionario Critico, il bibliofilo e bibliotecario Allibone, definendolo amico, ispiratore e collaboratore. Così a scavare oltre, viene fuori che lo zio Robert collaborò alla stesura di alcune biografie comprese nell’opera di Allibone. Mi viene naturale immaginare che tra queste ci infilò anche stavolta la propria:
Mackenzie, R. Shelton, M.D., D.C.L., n. 1808, in Limerick, Irlanda, è il secondo figlio del capitano Kenneth Mackenzie, autore di un volume di poesia gaelica, Glasgow, 1796 (ante). Il soggetto delle nostre note studiò medicina a Cork, si laureò a Dublino, ma non esercitò mai (…)
Ed esagerando, pure quella del genitore:
Mackenzie, capitano Kenneth, padre di R. Shelton Mackenzie, D. C. L. (post), fu l’autore di un volume di poesia gaelica pubblicato a Glasgow nel 1796.
E quella del nipote:
Mackenzie, Kenneth. Dr. C. R. Lepsius’s Discoveries in Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai in 1842–45, edito, con Note, da K. M.; 2a ed., Lon., 1853, 8vo. Il valore di quest’opera è ben riconosciuto.
Questa “autobiografia” viene da quel momento ripresa da tutte le successive occorrenze, quasi parola per parola, senza aggiungere nulla di nuovo, fino a essere per così dire ufficializzata in
Sidney Lee, Dictionary of National Biography, Vol. XXXV, New York: MacMillan and Co., 1893.
L’unica eccezione:
MACKENZIE, ROBERT SHELTON (22 Giugno 1809–21 Novembre 1881), autore, giornalista, nacque a Drew’s Court, contea di Limerick, Irlanda, secondo figlio del capitano Kenneth Mackenzie dei Kaithness Fencibles, successivamente direttore delle poste nella piccola cittadina militare di Fermoy. Sua madre fu Maria Shelton Mackenzie. Robert fu educato in una scuola di Fermoy, dove nel 1825 iniziò a insegnare.
Dumas Malone, Dictionary of American Biography, Vol. XII, New York: Charles Scribner’s Son, 1943
L’autore della voce, Albert C. Baugh, anziché ribadire pari pari la biografia che già circolava, verificò in prima persona, parlando con Marion Mackenzie, figlia di Robert Shelton. Ringrazio quindi la nipote di Kenneth per aver specificato il nome del reggimento presso il quale prestò servizio nonno Kenneth, ma soprattutto per aver svelato il nome della nonna: Maria Shelton.
Insisto
a scandagliare la vita di Robert Shelton. L’impressione che fosse un
soggetto piuttosto ciarliero e vanaglorioso mi fa sperare che dai suoi
scritti si possano estrapolare informazioni personali e familiari.
Aneddoti sulla vita di nonno Kenneth, antenati e parentela varia, sono ad esempio nascosti in un’opera di pseudo autofiction.
Robert Shelton Mackenzie, Mornings at Matlock, Londra: Henry Colburn, 1850.
Una
collezione di racconti precedentemente editi singolarmente in riviste e
almanacchi, raccolti e riarrangiati in una cornice che «se non è
considerevole per originalità di costruzione, almeno è ben progettata
per produrre una gran varietà di storie», come commentò il critico de The Spectator dell’epoca.
Praticamente
alcuni turisti, tra i quali l’autore, in visita ognuno per proprio
conto nella località di Matlock, si incontrano casualmente e decidono in
modo molto poco inglese di essere socievoli. Formano una sorta di
compagnia, condividendo i momenti di ristoro e di convivialità, godendo
del divertimento, razionale oltre che piacevole, del chiacchierare
spensieratamente fino a mezzanotte.
Un ex ufficiale dell’esercito in
pensione, un illustratore, uno scrittore, un gentiluomo irlandese e un
giornalista, ai quali si aggiungono in seguito altri compagni,
compongono una combinazione di persone di varia estrazione e diversa
provenienza, ognuna delle quali nel corso delle serate sforna
conversazioni sulle eccentricità che occasionalmente si incontrano nel
corso della vita.
In una di queste, intitolata The Second Sight, il personaggio dell’illustratore intrattiene gli altri con il ricordo di un dialogo avuto anni prima con un gentiluomo delle Highlands. Lo scozzese gli parlò dell’eredità di famiglia, due oggetti di valore storico e affettivo, tramandati dal nonno al padre e infine giunti al nipote.
Una tabacchiera scozzese, molto semplice, senza il minimo ornamento, tranne un piccolo gancetto d’argento sul coperchio, per aprirlo, e un leggero bordo dello stesso metallo, attorno alla parte superiore. Sul coperchio era stato inciso frettolosamente qualcosa come uno scudo, contenente ciò che, da discreto conoscitore di araldica, ero certo rappresentare una testa di cervo caboshed…
E un piccolo ritratto del Bel Principe Carlo, il Giovane Pretendente degli Stuart.
Una miniatura ovale, chiaramente incastonata in ottone dorato — pinchbeck, come in seguito fu chiamata dal gioielliere che la introdusse. La somiglianza non dava adito a dubbi. I capelli chiari, gli occhi azzurri e i lineamenti allungati del Cavaliere erano stati spesso descritti e sono ben noti. C’era il nastro azzurro della Giarrettiera, la stella di quell’Ordine sul petto, la cravatta di pizzo, il mantello di tartan blu grigiastro striato di rosso, e il mantello cremisi bordato di ermellino.
Il gentiluomo scozzese fu lieto, oltre che orgoglioso, di spiegare al proprio interlocutore come il nonno fosse venuto in possesso di tali oggetti:
Mio
nonno, che risiedeva vicino a Culloden Moor, aveva preso moglie poco
prima della seconda sommossa giacobita. La mattina del 15 aprile 1746 si
sedette a fare colazione con un aspetto così grave, che la sua sposa fu
indotta a chiedere quale circostanza l’avesse talmente rattristato.
Tentò di eludere l’indagine, che l’affetto e la curiosità femminili gli
avevano rivolto, ma lei lo incalzava così strettamente sul punto, che
confessò di aver visto un’ombra malevola in arrivo. Che in poche parole,
aveva visto, o meglio, previsto, un sanguinoso combattimento, vicino
alla loro abitazione, in cui la sconfitta degli Highlanders in kilt, da
parte dei soldati in giubba rossa della dinastia Hannover, avrebbe
inevitabilmente causato la sconfitta del Cavaliere. Mio nonno era lui
stesso un sostenitore degli Stuart, e il capo del nostro clan aveva
perso la sua contea e le sue proprietà, ed era scampato per un pelo alla
morte, a causa della sua partecipazione attiva alla ribellione del
1715.
«Ma», disse mio nonno, «ho visto anche, mia Isabella, che
questa sera riceveremo sotto il nostro tetto un condottiero valoroso e
regale. Non può essere altro che il Principe, e ti conviene prepararti
al meglio per lui».
In Scozia, a quel tempo, il motto della moglie
era: udire e obbedire, e colei a cui si era parlato così, si affrettò a
mettere in ordine la sua casa, e prepararla per l’accoglienza
dell’ospite previsto. Pochi minuti prima di mezzanotte udirono
avvicinarsi gli scalpiti della cavalleria. Si avvicinarono, sempre più,
fino a quando i cavalli si fermarono davanti al cancello di mio nonno.
Un forte bussare fece uscire gli inquilini, che ricevettero come
pretendente alla loro ospitalità uno che certamente era un capo reale,
ma non esattamente colui che si aspettavano. Invece del bel Principe
Carlo, si presentò loro il Duca di Cumberland, allora un uomo forte ed
energico, che compiva venticinque anni proprio quel giorno.
Il duca
era partito da Nairn, all’inseguimento delle truppe giacobite del
Principe Carlo, e sebbene avesse trascorso la maggior parte della notte
in sella, si limitò a una sola ora di sonno, stendendosi senza togliersi
i vestiti. Uscì di casa all’alba e ciò che rimase più impresso nella
memoria dei miei parenti fu che mangiava in modo vorace e consumava
enormi quantità di tabacco da fiuto, o sneeshen, come veniva chiamato
allora.
Mentre se ne andava, chiese in prestito una tabacchiera a mio
nonno. Il peggio della casa, vale a dire una comune tabacchiera
scozzese, gli fu riempita e consegnata, perché, per così dire, a
prescindere dalle simpatie di mio nonno per gli Stuart, non si sarebbe
mai aspettato di rivedere il suo prestito. Due o tre giorni dopo la
battaglia, invece, un soldato giunse a cavallo alla casa, chiese il nome
del suo occupante, e gli restituì la tabacchiera, con i complimenti e i
ringraziamenti del Duca! Una volta aperta, si scoprì che era piena
d’oro. In tal modo il Duca aveva deciso di fare i suoi ringraziamenti
per l’ospitalità, consapevole che gli fosse stata concessa a malincuore.
Fatalmente, il nonno veggente incontrò anche il giovane Principe Carlo poco dopo la sua sconfitta:
«Il Bel Principe Carlo visse molte avventure romantiche, con una taglia di trentamila sterline sulla testa, prima di riuscire finalmente a fuggire in Bretagna. In una di queste occasioni, mio nonno gli rese un servizio, facendogli la guardia a rischio della sua stessa vita, e quando si separarono, il Cavaliere gli mise in mano la sua miniatura, dicendo: «Se mai la fortuna dovesse sorridimi, fammi vedere questo, e non mi troverai ingrato!»
Nonostante l’espediente letterario di spargere i ricordi dell’autore tra il narratore, i vari personaggi e i protagonisti dei loro racconti, alla fine, nella postfazione in cui Robert Shelton indica le rispettive proporzioni di fatti e fantasia nelle storie che compongono l’opera, specifica che i ricordi di The Second Sight:
… si riferiscono ad avvenimenti nella mia stessa famiglia, ai quali credo fermamente, anche se non riesco a spiegarli. La tabacchiera prestata da mio nonno al duca di Cumberland e da lui usata nel fatale giorno di Culloden è ora in mio possesso, così come la miniatura del giovane cavaliere.
Sotto la luce di tale dichiarazione, la storia del gentiluomo delle Highlands mi appare per quello che è, il ricordo dell’autore per i nonni paterni. Una storia è sempre una storia, ma in tale finzione narrativa ritengo che alcuni elementi siano sufficientemente verosimili da essere presi in considerazione. Proseguendo pertanto nella lettura del racconto, adoperando sempre cautela nel trasferire i fatti narrati nella vita reale, apprendo ulteriori dettagli sulla possibile storia della famiglia, anche e soprattutto sulla gioventù di nonno Kenneth.
Nella
mia stessa famiglia, la Seconda Vista è stata esercitata da tempo
immemorabile. In altre famiglie scozzesi, o meglio, nelle poche che
possiedono questa visione profetica, il dono si tramanda di padre in
figlio; nella nostra, a causa di una circostanza che sarebbe noioso
raccontare, invece si succede di nonno in nipote. Potrei raccontarti un
aneddoto o due, per mostrare come questo è stato il caso nella mia
famiglia.
L’ultima occasione, avvenuta più di mezzo secolo dopo [la visione della battaglia di Culloden],
mio nonno visse fino all’estrema vecchiaia, fu quella che i suoi
discendenti che ne avevano sentito parlare, non avrebbero probabilmente
mai dimenticato.
Mio padre, essendo di indole capricciosa, come
Orazio nella Commedia, prese congedo francese dal suo luogo di nascita
appena ebbe diciotto anni. I quindici anni seguenti furono testimoni
delle sue peregrinazioni in ogni parte del globo, e durante tutto quel
tempo egli indubbiamente trascurò di mantenere qualsiasi comunicazione
con la sua famiglia per lettera. I suoi parenti credevano generalmente
che fosse morto; ma suo padre dichiarava a tutti di pensare il
contrario, e sua madre si aggrappava affettuosamente alla stessa
convinzione con la fiducia che solo i sentimenti di una madre possono
conservare.
Solo infine, quando la sua stessa memoria fu quasi
dimenticata, tranne che dai suoi genitori, l’assente di lungo corso
riapparve sulle scene della sua giovinezza. Il modo in cui fu ricevuto,
come l’ho sentito raccontare, fu inesprimibilmente sorprendente.
Il
padre, oramai bianco e piegato dai mali degli ottant’anni e passa, aveva
però mantenuto inalterate la maggior parte delle sue facoltà mentali,
ed era amato, tra i suoi figli e i figli dei suoi figli, come un
patriarca, un legame vivente tra il passato e il presente. Nel
trentatreesimo anniversario della nascita del figlio assente, che
avevano continuato a celebrare più per consuetudine che per credenza
nella sua esistenza, il vecchio esclamò improvvisamente, fissando gli
occhi sbarrati verso la finestra aperta: «Vedo il ritorno dell’assente:
stanotte la sua voce risuonerà nella casa in cui ha respirato la prima
volta». Non disse una parola in più, ma sua moglie, che aveva piena
fiducia nella sua Seconda Vista, ordinò che si facessero subito i
preparativi per l’accoglienza di un ospite.
La giornata stava
volgendo al termine e non era apparso alcun visitatore. I membri più
giovani della famiglia sorrisero, con scetticismo, per il mancato
compimento della previsione del vecchio.
Alla fine, quando ormai era
quasi mezzanotte, si udì rumore di passi provenire dall’esterno. La
finestra era stata lasciata aperta, e attraverso di essa, in maniera
piuttosto insolita e goffa, fece il suo ingresso un uomo robusto,
abbronzato dal sole di terre straniere, che aveva lasciato quel luogo
quando era solo un ragazzo. Nessuno lo riconobbe, tranne i suoi anziani
genitori. Si chinò in ginocchio, davanti al padre, per una benedizione; e
il vecchio, ponendo le mani sul capo del lungo assente, lo benedisse
con fervore, e poi esclamò, in segno di gratitudine: «Signore, ora
lascia pure che il tuo servo se ne vada in pace!» Trascorse un po’ di
tempo tra domande e risposte e, al mattino presto, la famiglia felice si
ritirò per riposare.
Quando si alzarono e si radunarono intorno al
tavolo della colazione, si accorsero che il posto di mio nonno era
vuoto. Una delle sue figlie andò a convocarlo. Perché devo prolungare
oltre questa storia? Lo trovò morto. Al suo fianco c’era sua moglie,
addormentata nella felice incoscienza della sua perdita. Se mai un cuore
si era spezzato di gioia, era quello di quel vecchio.
La memoria del nipote Robert Shelton si è rivelata una vena ricca di informazioni sulla vita del padre Kenneth, tale da poterne abbozzare una prima biografia.
La
famiglia originaria della contea di Inverness, apparteneva al ramo del
clan dei Mackenzie di Seaforth. I genitori si sposarono poco prima della
rivolta del 1745, la bisnonna si chiamava Isabel. Schierati con gli
Stuart e presumibilmente di fede episcopalista. Da questa famiglia, il
figlio Kenneth si staccò appena diciottenne. Lasciò l’isola per
viaggiare. Il ritorno dopo quindici anni (a oltre cinquanta di distanza
dalla battaglia di Culloden), il tempo di ricongiungersi con la
famiglia, che il padre morì. Di lì a poco Kenneth pubblicò un libro di
poesie e prima della fine del secolo era arruolato nell’esercito. Nei
Kaithness Fencibles, dei quali in seguito diventò il capitano. Una volta
congedato si acquartierò in Irlanda. Impalmò l’irlandese Maria Shelton e
nacquero almeno tre figli maschi che crebbero a Fermoy, dove Kenneth fu
nominato direttore dell’ufficio postale.
Oltre al collegamento
temporale con le nozze dei genitori di Kenneth, la data storica della
fine delle speranze giacobite segna anche i cinquant’anni trascorsi da
allora a quando Kenneth ritornò e il padre morì, permettendo così di
collocare approssimativamente gli eventi. Se nel 1797 circa Kenneth
aveva trentatre anni, allora sarebbe nato approssimativamente nel 1764.
Marinaio dal 1782 al 1796, quando sarebbe morto il padre e avrebbe
pubblicato le proprie poesie.
Per quanto possa essere stato sincero e fedele ai fatti, per potermi affidare ai ricordi del nipote Robert Shelton ho bisogno di qualche riscontro esterno che convalidi o meno i suoi racconti familiari.
Gli anni delle peregrinazioni di nonno Kenneth sono imperscrutabili. Escludendo che abbia intrapreso un Grand Tour alla maniera dei rampolli dell’aristocrazia europea, per girare il mondo autofinanziandosi, o si arruolò nella Marina Reale, o nella Compagnia delle Indie Orientali o fu assunto da qualche altra impresa commerciale internazionale. A meno che non avesse letteralmente vagabondato. In ogni caso, non sembra che quest’attività lo abbia portato a chissà quale carriera che meritasse di essere menzionata nella letteratura.
Viro
le indagini sulla sua attività artistica, sembra che abbia pubblicato
un libro di poesie in gaelico nel 1796, quindi qualche traccia nella
storia della letteratura di questa lingua potrebbe averla lasciata. E
infatti, dove se non alla Gaelic Society of Inverness, fondata nel 1871
allo scopo di coltivare la lingua, la poesia e la musica delle Highlands
scozzesi?
Durante una lettura tenuta davanti ai membri della Società, il 5 Maggio 1972 e pubblicata col titolo Notes on Bards, in Transactions of the Gaelic Society of Inverness, Volume XLVIII,
Hugh Barron, il relatore, si augurava che i nomi degli antichi bardi
locali rimanessero nella memoria dei futuri scozzesi, indipendentemente
dalla qualità dei loro versi. Tra compositori che potevano degnarsi di
tale titolo e semplici rimatori, tra i bardi di Inverness, Barron citò
un Kenneth Mackenzie, che nacque a Caisteal Leathair nel 1758 e morì a
Fermoy nel 1819. Il fratello del quale fu J. C. MacKenzie, proprietario
della rivista Galignani
a Parigi. Il suo libro di poesie gaeliche uscì nel 1792. Il padre di
Kenneth, deceduto nel 1806, riposa nel cimitero di High Church ad
Inverness. Barron finiva citando The Celtic Magazine, Vol. V, pagina 398 come depositario di ulteriori particolari.
Come
dovevo aspettarmi, gli scrupoli sull’affidabilità di una fonte unica e
per di più parziale, non sono mai inutili. Tra zio Robert e questo Hugh
Barron, qualcuno si sbaglia. Per il primo la nascita sarebbe avvenuta
all’incirca nel 1764, per l’altro nel 1758. Per il volume delle sue
poesie ci danno rispettivamente 1796 e 1792. Se la data corretta fosse
la seconda, ovviamente non avrebbe potuto essere ancora imbarcato su
qualche nave in mezzo all’Atlantico e allo stesso tempo far pubblicare
il libro a Glasgow.
Pure sulla morte del padre c’è discordanza, per il nipote avvenne il giorno del trentatresimo compleanno del figlio, 1796 circa, Barron, che sembra più informato, dice 1806.
Vedo di recuperare il volume di The Celtic Magazine al quale Barron rimanda alla fine della sua lettura, e mi auguro aiuterà a chiarire alcuni punti.
The Celtic Magazine: A Monthly Periodical devoted to the Literature, History, Antiquities, Folklore, Traditions, and the Social and Material Interest of the Celt at Home and Abroad. Conducted by Alexander Mackenzie, F.S.A. Scor., Vol. V, Inverness: A. & W. Mackenzie, 1880.
In cui appare, suddiviso in nove parti sparse tra un saggio e l’altro, il resoconto di un tour nordamericano compiuto dallo stesso editore della rivista. L’ultimo capitolo, dal titolo New York and Philadelphia — Indipendence Hall and Robert Shelton Mackenzie, avrebbe potuto essere l’incipit di questa ricerca, e avrebbe risparmiato tempo a chi scrive e a chi legge.
Carroll
mi presentò anche un gentiluomo, il nome del quale non mi era del tutto
sconosciuto per fama e che, a parte la sua posizione nel mondo
letterario americano, fui lieto di incontrare come anello di
congiunzione tra il presente e il passato, soprattutto per il suo legame
con Inverness. Questo era il dottor Shelton Mackenzie, noto
nell’ambiente della stampa americana e come autore di notevole
reputazione. Scrisse le vite di Dickens e di Scott, che in brevissimo
tempo ebbero diverse edizioni; curò l’edizione americana delle “Noctes
Ambrosiane”, così come molte altre opere degne di nota. È fratello del
defunto J. C. Mackenzie, di Parigi, editore di Galignani, morto poche
settimane dopo che ero stato a Filadelfia, e figlio di Kenneth
Mackenzie, il bardo di Inverness, di cui il defunto John Mackenzie dà il
seguente interessante resoconto nelle sue “Bellezze della poesia
gaelica”.
Kenneth
M’Kenzie nacque a Caisteal Leauir’ (Castle Leather), nei pressi di
Inverness, nel 1758. I suoi genitori erano economicamente agiati e
poterono fornirgli il vantaggio di una buona educazione. A circa
diciasette anni divenne apprendista marinaio e iniziò a imbarcarsi per
lunghe missioni in mare. Quelli erano gli anni della rivoluzione
americana, ed è quindi probabile che assistette in una certa misura ad
alcuni conflitti navali e che fosse aggiornato sull’andamento della
guerra attraverso le sue reti di conoscenze marinaresche.
Per i vari
momenti di riposo dalle attività di bordo, aveva portato con sé la
Bibbia regalatagli dalla madre prima della partenza e le raccolte delle
opere di poemi in gaelico di Alexander Macdonald e Duncan Mac-Intyre.
Queste opere, che lesse, rilesse, studiò e rimuginò mentre era cullato
dalle lontane onde blu, alimentarono naturalmente la fiamma latente
della poesia che giaceva dormiente nel suo petto. I suoi ricordi
ritornarono ad aleggiare attorno agli episodi e sulle abitudini della
sua infanzia. Attraverso la vista magica del genio poetico, ogni oggetto
del suo passato si appropriava di un nuovo fascino, e così intrecciava i
suoi affetti intorno al suo paese natale e alla sua lingua vernacolare,
il valore e la bellezza dei quali la distanza tendeva a fargli
apprezzare maggiormente.
In questo periodo lontano dalla terraferma
probabilmente iniziò a comporre i suoi primi versi in idioma gaelico.
Piobairachd na Luinge era un tentativo di imitazione dell’inimitabile
Beinn-dòrain di M’Intyre, ma non aveva alcuna pretesa di paragonarsi a
quel capolavoro. Non siamo sufficientemente preparati per dire quale sia
la migliore scuola per l’ispirazione poetica, né per rifinire e
maturare il genio poetico; ma ci azzardiamo ad affermare che le
abitudini di un uomo di mare abbiano un’influenza deteriorante sui
sentimenti di gioventù. Kenneth M’Kenzie è evidentemente nato con
talento e genio, ma nonostante l’imponenza dell’opera pubblicata,
possiamo trovare solo quattro o cinque pezzi nei quali sia riuscito a
superare i confini della mediocrità.
M’Kenzie abbandonò la vita in
mare nel 1789 e iniziò a raccogliere le sottoscrizioni che gli
permettessero di pubblicare la sua prima raccolta di poesie. Con la
nostra venerazione per il carattere di un poeta, ripudiamo con forza
quella rigida brutalità che lussureggia negli insulti ai devoti alle
muse. Gli uomini di genio sono sempre, o quasi sempre, uomini di
sensibilità, e di buoni e acuti sentimenti; e ci appare inspiegabile
come un uomo possa ricavare piacere dal suscitare le indignazioni altrui
e ferendo i sentimenti del prossimo. Il bardo itinerante a caccia di
finanziamenti fu anch’egli oggetto di infime derisioni da parte di
piccoli uomini. Contro di lui gli uomini di vile argilla lanciarono il
loro ariete, e il nostro autore sembrò accusare gli attacchi. Quando
si rivolse a Alexander M’Intosh, di Cantray Down, questi non solo
rifiutò di aiutarlo, ma lo cacciò anche in modo burbero dalla sua porta!
Certamente
un diniego educato sarebbe costato a quell’altezzoso gentiluomo tanto
poco quanto il suo rifiuto, dopotutto scuse di natura tollerabilmente
credibile si possono trovare al momento per quasi ogni mancanza. Così
non fu e il nostro bardo, indegnamente insultato, si vendicò in una
satira di grande pregio. In questa cinica produzione egli effuse periodi
di fuoco; e un impetuoso torrente di amara ironia e appassita
declamazione ricco di ingredienti essenziali del suo genere; e
Mackintosh, che non rimase impenetrabile alle frecce del rimorso, morì
tre giorni dopo che la satira pubblicata arrivò in suo possesso.
Afflitto da questo evento doloroso, e conoscendo bene le superstizioni e
i pettegolezzi che avrebbe ingenerato nei suoi compatrioti, Mackenzie
tornò dai suoi sottoscrittori, chiese loro indietro i libri da chi
poteva essere persuaso a rinunciarvi, e li consegnò alle fiamme;
un’indicazione sufficiente del suo dolore per la sua impietosa e, come
pensava, fatale destino di Mackintosh. Questo spiega la scarsità dei
suoi libri in circolazione.
Poco dopo questo evento, il suo carattere
e il suo talento generale attirarono l’attenzione di Lord Seaforth e
del Conte di Buchan, l’influenza dei quali, combinata insieme, gli
procurò il rango di ufficiale del 78° Highlanders.
Avendo abbandonato
l’esercito, accettò il posto di direttore delle poste in una piccola
città della provincia irlandese, dove si abbandonò alla genuina
ospitalità del suo cuore, tenendo sempre la porta aperta e la tavola
apparecchiata, e accarezzando letteralmente i suoi connazionali che per
caso o affari convenivano alla sua dimora.
Abbiamo conversato con un vecchio veterano che è stato partecipe della sua generosità fino almeno all’anno 1837.
Di
persona Kenneth Mackenzie appariva alto, bello e robusto, appassionato
di barzellette e sempre l’anima di ogni circolo che frequentava. Se le
sue poesie non mostrano grandi vette di genio, non sono però mai piatte;
anche se il suo torrente non scorre sempre con impetuosità, non
ristagna mai; come assaporare una facile navigazione con la corrente a
favore, come accettare volentieri un invito a fare un viaggio con il
nostro poeta marinaio.
L’autore
di questa biografia, il defunto John Mackenzie, fu un ricercatore e
divulgatore di letteratura gaelica, una sorta di etnografo delle
Highlands. Nato a Mellon Charles, nella contea di Gairloch, nel 1806;
sia il padre, Alexander Mackenzie, che possedeva alcune terre sul lato
nord di Loch Ewe, che la madre, vantavano una parentela con i laird di
Gairloch (titolo equivalente a quello di esquire in Inghilterra), lo
stesso clan di Kenneth. La famiglia era da alcune generazioni in
condizioni confortevoli e John beneficiò di un’infanzia agiata. Istruito
inizialmente a casa da tutori privati, frequentò successivamente le
scuole sull’isola di Ewe e quella della parrocchia di Gairloch, dove
sviluppò un buon orecchio per la musica e la poesia. Allo stesso tempo
manifestò anche un altro talento: con il solo aiuto di un coltellino
tascabile era in grado di realizzare ogni sorta di oggetto in legno,
decorazioni, statuette e piccoli utensili. Da bambino si era addirittura
costruito da solo un violino e in seguito produsse una serie di
cornamuse, di cui divenne anche un discreto suonatore.
Mentre il
ragazzo riempiva il suo bagaglio culturale, nel frattempo la munifica
ospitalità del padre, abbinata allo sfarzoso stile di vita allora in
voga tra i tacksmen (beneficiari o affittuari di terreni di proprietà
del laird, dei quali tengono una parte e sub-affittano la restante),
fecero dimenticare la buona amministrazione delle terre che il laird Sir
Hector Mackenzie aveva affidato alla famiglia. Tanto che il laird, si
vide costretto a riportarle sotto la propria gestione diretta per
rimediare all’incuria in cui versavano, concedendo ad Alexander
l’usufrutto gratuito di una piccola porzione a patto che saldasse i
propri debiti nei suoi confronti.
Fu allora che i genitori di John
ragionarono che il figlio avrebbe potuto garantirsi un futuro migliore
investendo nella sua abilità di intagliatore. Lo affidarono come
apprendista a un falegname itinerante di nome William Ross affinché
imparasse il mestiere, ma le peregrinazioni di villaggio in villaggio,
che maestro e allievo affrontavano alla ricerca di lavoro, si
trasformarono per il ragazzo in occasioni perfette per imparare le
canzoni e le arie popolari che sentiva intonare presso le case dei
clienti che richiedevano il loro servizio e nelle taverne dove si
fermavano per ristorarsi. Probabilmente cominciò allora a trascrivere le
liriche su carta, come promemoria per imprimerle più facilmente nella
mente.
Era più o meno il 1825 e un incidente di lavoro costrinse John
a rinunciare al suo futuro nella falegnameria. Quello che sembrò
immediatamente un accanimento del fato, si sarebbe rivelato a posteriori
la sua fortuna. John stava lavorando in un cantiere, quando cadde da un
muro in costruzione e subì un colpo alla testa che lo rese incapace di
lavorare. Dopo un po’ sembrò essersi ristabilito e andò a Conon Bridge
per tentare di completare il suo apprendistato presso un altro
falegname, ma si scoprì che l’infortunio era di natura permanente, da
non essere più idoneo a proseguire nella professione.
Con pochi
rimpianti, mise da parte martello e chiodi e ritornò nella sua
parrocchia natale. Lì si dedicò alla sua vera passione, la lingua
gaelica e la sua letteratura. Il progetto era di recuperare e
sistematizzare il corpus di Uilleam Ros (William Ross, 1762–1791), non
il suo tutore di falegnameria, ma il Mór Ros, il Grande Ros, il bardo di
Gairloch, considerato il maggior esperto di gaelico della sua epoca.
In The Celtic Magazine, No. XVIII, Aprile 1877, Vol. II, appare un memoir
dedicato a John Mackenzie, scritto da un suo erede, Alexander
Mackenzie, fonte principale delle informazioni biografiche
dell’antenato, nel quale è narrato che prima di morire, Ross diede alle
fiamme tutti i suoi manoscritti. Per questo motivo non restava traccia
della sua produzione artistica, se non nella memoria di chi avesse avuto
la fortuna di ascoltarlo. Questo, più o meno, quanto John avrà
raccontato al nuovo laird di Gairloch, Sir Francis Alexander Mackenzie,
che si convinse facilmente a proporsi come patron dell’impresa. Con i
soldi del laird, John trascorse almeno quattro anni sulle tracce delle
canzoni di Ross. O quantomeno lo fece credere. Nel 1830 circa, infatti,
aveva grosso modo completato il lavoro e di trentuno poemi raccolti,
diciassette erano in realtà già apparsi in stampa nelle collezioni di
Stewart del 1804 e di MacLeod del 1811. Vero che le versioni di John
Mackenzie comunque presentavano spesso delle sostanziali differenze. I
quattordici componimenti inediti invece, sempre secondo il memoriale del
pronipote, furono recuperati soprattutto grazie a Alexander Campbell,
meglio conosciuto come Alastair Biiidhe Mac lamhair, un altro bardo
contemporaneo e intimo di William Ross. Mentre Campbell recitava le
poesie del defunto amico, il giovane Mackenzie registrava quei versi in
forma scritta per la prima volta dopo decenni.
Il passaggio in stampa però continuava a tardare. E John per sopravvivere aveva trovato impiego come agente dell’Inverness Courier
per la zona di Caithness. Attraversando le lande settentrionali della
Scozia, bussando di casa in casa per vendere abbonamenti al giornale, ne
approffittava per raccimolare qualche fondo da destinare a coprire i
costi della pubblicazione. Il laird probabilmente aveva chiuso i cordoni
della borsa. Come non bastasse, John stava riscontrando pure pressioni
ecclesiastiche sui suoi tipografi ed editori a Inverness. Il modello del
clan eroico cantato da Ross, in base al quale laird e tacksmen facevano
baldoria allo stesso tavolo mentre i fedeli piccoli fittavoli
guardavano, e le loro donne fantasticavano di dormire con il figlio di
un re su un letto di lino, contrastava con l’onda crescente di
fondamentalismo religioso che stava riempiendo i pulpiti di tutte le
Highlands.
Passarono quindi altri tre anni prima che riuscisse a mandare in stampa l’opera:
Orain Ghae’lach le Uilleam Ross, air an sgriobhadh, agus air an co’-chruinneachadh ri cheile le Iain Mac-choinnich ann an Inbheiriue. Inverness: R. Carruthers per Lewis Grant e D. Macculloch, 1833.
Dopodiché
preferì traslocare a Glasgow, sia per sfuggire alle attenzioni dei
fanatismi religiosi, sia che per intraprendere un’attività a lui più
congeniale, lo spaccio di letteratura al limite del legale.
In tale
ambiente trovò la possibilità di pubblicare una nuova edizione
dell’antologia del Mór Ros, riveduta e corretta, con l’aggiunta di un
altro paio di poemi sovvenuti a Campbell. Curò quindi l’edizione di una
raccolta di un altro bardo, Alastair Mac Mhaighstir Alastair, una
collezione di poesie d’amore e una selezione di canti delle Highlands.
Forse
l’attività, sebbene gratificante, non era sufficientemente
remunerativa, così nel 1836 fece in modo di ottenere il posto di
contabile presso la stamperia dell’Università di Glasgow. Occupazione
che oltre a una stabilità economica, gli lasciò anche sufficiente tempo
libero da dedicare a una nuova raccolta di poesie. Un progetto
ambizioso, di respiro più ampio rispetto a quanto edito fino a quel
momento, un’antologia il più completa possibile dei maggiori autori in
lingua gaelica, che aveva in mente da quando approcciò quella di Ross e
per la quale aveva accumulato nei suoi manoscritti materiale fin
dall’adolescenza. L’iniziativa avrebbe richiesto uno sforzo economico
che John non era in grado di sostenerlo da solo, nonostante le diverse
sottoscrizioni che tuttavia era riuscito comunque a raccimolare. Alcune
di esse però stavano scadendo e così si affrettò a vendere i diritti
d’autore a un prezzo irrisorio, agli editori Macgregor, Polson, &
Co. di 75 Argyle Street, Glasgow, impegnandosi allo stesso tempo ad
accollarsi le spese pubblicitarie. Prese in questo modo forma Bellezze della poesia gaelica, in cui il nostro Coinneach Mac Choinnich compare per la sua produzione poetica:
Sar-obair nam bard gaelach: or, The beauties of Gaelic poetry, and lives of the Highland bards; with historical and critical notes, and a comprehensive glossary of provincial words. By John Mackenzie, Esq., Honorary Member of the Ossianic Society at Glasgow, the Celtic Society of London, &c., &c.
Nella
nicchia della letteratura gaelica, questa raccolta occupa tutt’oggi una
posizione seconda solo al lavoro di Ossian. Il lavoro conta regolari
ristampe lungo tre secoli: una nuova edizione nel 1863, 1865 e 1867, la
terza edizione nel 1872, la quarta nel 1877, nel 1882 la quinta.
Un’edizione aggiornata esce nel 1904 e infine arriviamo a un’ultima
pubblicazione nel 2017. Insomma, un vero testo chiave nella formazione
del canone gaelico.
Introdotte dalla prefazione in inglese sulla storia e la poesia dei Celti, scritta da James Logan, autore di The Scottish Gael, vengono
presentate oltre duecento poesie in lingua originale, insieme alle
biografie in inglese dei relativi trentasei autori, per finire con
un’appendice di altri dodici poemi di compositori minori. Indubbiamente
il curatore avrà viaggiato per oltre dodici anni attraverso le
Highlands, incontrato qualche vecchio bardo del secolo precedente o i
suoi posteri, venendo in possesso di rari, se non unici, componimenti di
innegabile valore storico, che nelle sue trascrizioni hanno potuto
essere preservati, ma è pur vero che anche qui, sul totale di
duecentocinquantadue esemplari presentati, solo dodici erano originali.
Così come i curiosi e interessanti aneddoti in merito ai bardi e ai
retroscena che ispirarono le loro liriche, provenivano per lo più dal
prozio di John, James Robertson, che di qualche anno più anziano, aveva
molte informazioni e ricordi sulla vita dei poeti delle generazioni
andate.
Ma a John Mackenzie premeva innanzitutto colmare il divario
tra il gaelico e l’inglese, scrollando dalla lingua dei Gaeli la patina
di antiquariato. Seppur gli eroi della tradizione fossero reputati una
materia degna di studio, le vite e i pensieri della gente comune delle
generazioni più recenti non godevano della stessa considerazione: per
quanto le loro canzoni potessero avere una propria dignità, non potevano
certo avere un valore artistico e figurarsi essere considerate
letteratura. Ecco anche perché i poeti gaelici non erano chiamati poeti,
ma bardi; ecco perché Mackenzie insistette proprio nel chiamarli poeti,
imprimendo la parola ‘poesia’ direttamente in copertina.
Le
tracce lasciate da Kenneth sulla propria esistenza fin qui reperite,
siano gli aneddoti raccolti da John Mackenzie, siano i ricordi del
figlio Robert Shelton e della nipote Marion,
a eccezione forse della data di morte del padre fornita da Barron, sono
tutte informazioni di seconda mano. Componendo i vari elementi comunque
emergono alcune precise circostanze, seppur dai vaghi contorni, ma che
si convalidano reciprocamente.
Tra queste certezze abbiamo il fatto
che Kenneth fosse originario di Inverness, che presto si allontanò da
casa e che al suo ritorno, attorno ai trenta anni di età, pubblicò un
libro di poesie. Che per un certo periodo servì per l’esercito
britannico e finì a vivere in Irlanda, dove accettò un posto da
direttore delle poste.
Sulle date invece c’è sempre disaccordo.
Quando nacque? Per John Mackenzie senza ombra di dubbio nell’anno 1758,
mentre sarebbe più giovane secondo la memoria messa in prosa dal figlio.
Il libro uscì nel 1792 o nel 1796? Ma anche il caso dell’arruolamento,
che sempre Mackenzie di Gairloch afferma che Kenneth combatté negli
Highlanders condotti dal capo clan Mackenzie, quando la nipote che non
lo ha mai conosciuto, nomina un misconosciuto Kaithness Fencibles. Sulla
morte pure c’è discordanza, 1837 o 1819.
La situazione potrebbe essere riassunta da questo articolo apparso in The Highland News del 6 maggio 1899:
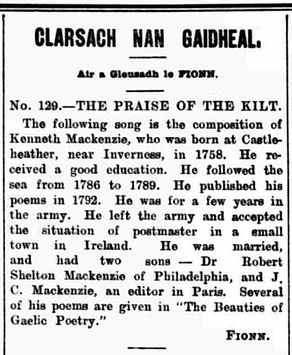
A quanto dice Fionn bisognerebbe aggiungere alcune precisazioni. La versione beta della biografia di Kenneth dovrebbe rendere conto delle riserve sulla nascita; a Castle Leather, una diocesi rurale vicino Inverness, va bene, ma la data? Formalmente dovrei dire 1760 ± 5 anni. La madre forse si chiamava Isabel. Del suo addio a parenti, casa, patria, non c’è dubbio, per fare cosa, propendo a credere a John Mackenzie: il marinaio. Non so a chi credere invece per i margini temporali. L’articolo sopracitato circostanzia il tutto a tre anni, dal 1786 al 1789, ma così non si incastra con quanto sostenuto dai Mackenzie Robert e John. Sicuramente il ritorno in Scozia va datato entro il periodo 1792-1796, possibili date in cui furono stampati i suoi componimenti, e quindi termini ante quem per il suo abbandono dalle avventure marinare. È poi sicuro il suo breve periodo sotto le armi, prima di congedarsi e stabilirsi in Irlanda, inizialmente nella contea di Limerick e poi in quella di Cork. Certo come le nozze con Maria Shelton e i loro tre figli maschi. Sono abbastanza sicuro del suo lavoro come direttore dell’ufficio postale di Fermoy, fino alla sua morte. Non tanto invece su quando questa sia avvenuta. Potrebbe essere nel 1819 come nel 1837, troppo vago.
Ai
miei occhi il difetto di questa essenziale biografia di Kenneth
Mackenzie si annida nella sua natura fondamentalmente testimoniale e
derivativa. Che non mi può accontentare.
Fortunatamente la Ragnatela
Globale oggi rende disponibili documenti sociali di prima mano, fonti
storiche primarie, provenienti da parrocchie, archivi statali e
biblioteche, e si sa, allorché verba volant piuttosto carta canta.
Mi sembra logico partire dalle origini. Da Inverness, dal padre veggente e dalla madre forse chiamata Isabel, dalla sua presunta nascita nel 1758 a Castle Leathers. Con queste consegne, l’esito della ricognizione mi sbatte davanti un Mackenzie sepolto a Inverness nel 1806, come dicevano alla Gaelic Society. Sarà solo una coincidenza, ma in Scotland Monumental Inscriptions è presente la trascrizione di una lapide nel cimitero della Old High Church:
In memoria di Kenneth McKENZIE, agricoltore, Milltoun, Culduthell, morto il 26 Novembre 1806, all’età di 81 anni; e la sua sposa Isabell DENOON, morta il 12 Gennaio 1809, a 78 anni; e il loro figlio Donald MACKENZIE, morto il 25 Aprile 1844, a 71 anni; e la sua sposa Barbara SMITH, morta il 15 Marzo 1859, a 79 anni d’età.
Ora,
zio Robert ha dato prova di essere poco preciso nei dettagli, quindi
può aver confuso Culduthel con Culloden Moor (o forse quest’ultima
località era più congeniale per la sua narrazione), ma qui il nome della
nonna è lo stesso. Sebbene meno decisivo, coincide anche la sua
testimonianza sulla longevità. E comunque, a parte tutte le parole di
Robert, Coinneach Mac Coinneach, come ci si doveva aspettare, è
effettivamente “figlio di Kenneth”.
Ma come assicurarsi che sia proprio questo il padre del nostro Kenneth?
Per controprova cerco nei registri parrocchiali dei matrimoni scozzesi i seguenti filtri:
Cognome: M*kenzie
Nome: Kenneth
Nome della sposa: Isabel
Cognome della sposa: Denoon
Luogo del matrimonio: Inverness
Ed escono due risultati:
Data del matrimonio: 7 gennaio 1752
Luogo: Inverness
Nome(i): Kenneth
Cognome: Mackenzie
Nome(i) della sposa: Isabel
Cognome della sposa: Denoon
Data del matrimonio: 7 gennaio 1753
Luogo: Inverness
Nome(i): Kenneth
Cognome: Mackenzie
Nome(i) della sposa:Isabel
Cognome della sposa: Denvon
A
parte l’evidente errore di trascrizione di uno dei due certificati, che
rende incerto l’anno, i coniugi sepolti nel cimitero della Old High
Church si unirono in matrimonio nel 1752 o 53 (secondo zio Robert era
stato poco prima del 1745…) sempre a Inverness.
Nel database dei
registri parrocchiali dei battesimi in Scozia è conservato anche il
certificato di battesimo del figlio Donald sepolto con loro:
Nome: Donald
Anno di nascita: 1772
Data del battesimo: 17 settembre 1772
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kennath McKenzie
Nome della madre: Isabel Denoon
E fin qui tutto torna. Quindi nei medesimi registri dei battesimi cerco eventuali fratelli e sorelle, tra i quali spero proprio ci sia un Kenneth.
Cognome: M*kenzie
Anno di nascita: 1752–1772
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenn?th
Nome della madre: Isabel Den?on
Salta fuori che sono ben sei:
Nome: David
Anno di nascita: -
Data del battesimo: 24 agosto 1756
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenneth McKenzie
Nome della madre: Isabel Denoon
Residenza: Castle Leathers
Nome: Margrat
Anno di nascita: 1760
Data del battesimo: 23 agosto 1760
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenneth McKenzie
Nome della madre: Isobel Denoon
e ta-da! ecco qui
Nome: Kenneth
Anno di nascita: -
Data del battesimo: 8 ottobre 1762
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenneth McKenzie
Occupazione del padre: Fittavolo
Nome della madre: Isobel Denoon
Nome: Anne
Anno di nascita: 1765
Data del battesimo: 3 maggio 1765
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenneth McKenzie
Nome della madre: Isabel Dunoon
Residenza: Culduthel
Nome: Isobel
Anno di nascita: -
Data del battesimo: 5 agosto 1767
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenneth
Mackenzie
Occupazione del padre: Fittavolo
Nome della madre: Isobel Denoon
Residenza: Castle Leathers
Nome: Mary
Anno di nascita: -
Data del battesimo: 15 settembre 1769
Luogo del battesimo: Inverness
Nome del padre: Kenneth
McKenzie
Nome della madre: Isable Dunoon
Residenza: Culduthel
Quindi
bisnonno Kenneth era fittavolo di una terra del laird o di uno dei suoi
tacksmen, motivo per il quale probabilmente la famiglia si spostava
continuamente tra Castle Leather e Culduthel. Sempre più probabile che
quel terzogenito del 1762 sia il nostro Kenneth.
Negli appunti di
John Mackenzie di Gairloch la data di nascita sarebbe così sbagliata —
Kenneth è di quattro anni più giovane di quanto comunemente asserito —
nonostante questa imprecisione, il Sar-obair
è l’unico documento al quale fare riferimento in merito alla gioventù
di Kenneth. E del quale mi trovo obbligatoa fidarmi. Se avesse lavorato
nella marina mercantile, potrei rintracciare il suo nome in una qualche
lista di equipaggio di una qualche bastimento. Sebbene esistano tali
database, questi non sono indicizzati per i nomi dei marinai. Senza
conoscere il nome della sua imbarcazione, i porti che ha visitato e non
essendo stato un ufficiale, questo tipo di ricerca è tendenzialmente
impossibile, dovrei spulciare tutte le liste di ogni nave registrata in
qualsiasi porto tra il 1776 e il 1796. Nell’eventualità invece che
avesse prestato servizio nella marina militare, la ricerca online nei Royal Navy officers’ service records 1756–1931 agli Archivi Nazionali di Londra avrebbe dovuto rivelarmi qualcosa. Ma niente di significativo.
Passando
oltre a questo periodo oscuro, assodato che la sua vita al ritorno a
casa virò sul letterario, mi decido finalmente a recuperare la sua
raccolta di poesie, che in qualche biblioteca sarà stata conservata,
nonostante John Mackenzie abbia raccontato che lo stesso autore bruciò
la maggioranza delle copie. Da quanto scritto in precedenza, dovrebbe
essere passata dalle presse tipografiche tra il 1792 e il 1796. Glasgow
il probabile luogo di pubblicazione.
L’opera è digitalizzata
e non è stato difficile scovarla col suo nome in gaelico. Almeno una
ventina di copie sono conservate in biblioteche pubbliche col catalogo
accessibile, forse ne sono sopravvissute più di quante asserito in Sar-obair.
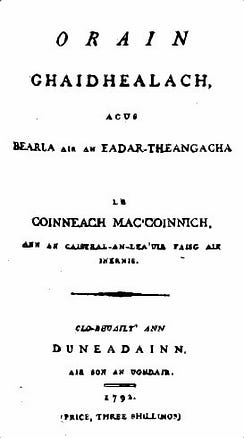 |
| Orain
Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha le Coinneach
Mac’Coinnich, ann an Caisteal-an-Lea’uir faisg air Inernis. Clo-Bhuailt’ ann Duneadainn. Air son an ughdair. 1792. |
Traducendo il frontespizio dal gaelico scozzese si apprende che le sue Canzoni delle Highlands
furono stampate a Edimburgo (Duneadainn) a spese dello stesso
autore nel 1792. L’errore sul luogo di stampa è comprensibile, all’epoca
i libri in gaelico scozzese erano tutti pubblicati o a Edimburgo o a
Glasgow, centri dell’industria tipografica rinomati a livello europeo,
dove non casualmente si trovava la maggiore concentrazione di lettori e
consumatori di prodotti editoriali, sebbene di lingua inglese, poiché le
più numerose comunità di parlanti gaelico vivevano nelle zone rurali.
Non
deve soprendere nemmeno l’autoproduzione del libro: a parte
l’inevitabile ricorso ai proprietari delle macchine tipografiche per la
realizzazione del prodotto fisico, all’epoca la relazione tra i poeti
gaelici e i propri lettori non era quasi mai mediata da editori, agenti
letterari e librai. Con l’effetto di una maggiore vicinanza tra la
cultura orale e quella della scrittura, ponendosi in una posizione
definita auralità. Tra autore e consumatore di letteratura gaelica il
rapporto era, si può dire, di conoscenza quasi personale. Il
finanziatore della produzione letteraria in lingua gaelica era allo
stesso tempo il consumatore del prodotto finale. Nella pratica questo
legame prese la forma delle liste di sottoscrizione, che
caratterizzarono tali pubblicazioni a cavallo tra Settecento ed
Ottocento.
Mackenzie infatti, come molti altri colleghi, raccolse in
prima persona le quote per finanziare l’uscita editoriale delle proprie
fatiche artistiche. Percorse a piedi, in lungo e in largo, tutta l’area
rurale tra Perth e Inverness.
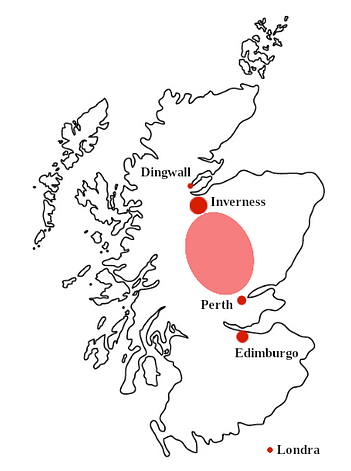 | |
| Distribuzione geografica dei sottoscrittori dell'opera di Kenneth Mackenzie |
Esaminando
la lista di sottoscrizione in appendice alla sua antologia, si può
verificare che le adesioni arrivarono a un totale di 993, collezionate
principalmente nella rete di relazioni familiari, amicali e
professionali. Soprattutto quindi nei luoghi in cui era nato e
cresciuto, l’area attorno a Inverness, che conta infatti settantanove
sostenitori. Poi trentasei a Edimburgo, ventisei a Perth, undici a
Dingwall e una soltanto a Glasgow. Nove a Londra. I residenti in un
contesto urbano rappresentavano il 15% circa del totale dei
finanziatori. La maggioranza si trovava invece nella zona rurale tra
Perth e Inverness, nei distretti di Atholl, Badenoch, Strathspey e
Rannocha.
Tra i sostenitori si annoverano immancabili illustri e nobili patrocinatori, per Mackenzie si scomodarono:
- David Stewart Erskine, il Conte di Buchan, al quale è dedicata l’intera opera, fondatore della Società degli Antiquari di Scozia e membro della London Society of the Friends of the People;
- il conte di Breadalbane;
- Francis Humberston Mackenzie, dal 1783 Signore di Seaforth e a capo del clan dei Mackenzie, membro del Parlamento, prossimo associato alla Royal Society e comandante del 78° reggimento di fanteria;
- il barone Norton di Edimburgo.
Oltre a 44 ufficiali dell’esercito reale, diversi ministri di Dio e tanta gente comune, medici, artigiani, commercianti.
Il
contenuto delle poesie di Mackenzie rispecchia queste relazioni con i
suoi lettori. Parecchie composizioni sono dedicate a precisi individui,
appellati per nome, cognome e provenienza. Facilmente per ammirazione e
riconoscenza, per sdebitarsi e per ringraziare commilitoni, colleghi
poeti, ma anche semplici compaesani. Tutti raccolti in una ristretta
cerchia di conoscenze, caratterizzata da una media di gradi di
separazione veramente ridotta. I poeti delle Highlands avevano questa
tendenza minimalista a limitarsi a un’agenda di temi locali, come a
rifugiarsi all’interno di un piccolo spazio protetto nel quale la
rievocazione delll’identità celtica offriva un essenziale conforto.
In
tale immaginario, dalla seconda metà del Settecento, dopo il fallimento
dell’ultima rivolta giacobita, entrò far parte anche l’esercito
britannico. La popolazione delle Highlands reagì con una sorta di
aquiescenza all’onta inglese e in pochi anni il fiero giacobitismo
popolare si travasò nella causa imperiale. Fondamentale, a questo
proposito, il Dress Act del 1746:
Che
a partire dall data del primo giorno di agosto
millesettecentoquarantasette, nessun uomo o ragazzo in quella parte
della Gran Bretagna chiamata Scozia, a parte quelli che saranno
impiegati come ufficiali e soldati nelle forze di Sua Maestà, dovrà, con
qualsiasi pretesto, indossare gli abiti comunemente chiamati abiti
delle Highlands (vale a dire) il plaid, il philabeg o il kilt, il
trowse, le cinture a tracolla o qualsiasi parte di ciò che appartiene
peculiarmente all’abbigliamento delle Highlands.
Fu
fatto inoltre divieto di suonare la cornamusa e persino di parlare
gaelico. L’esercito non soltanto divenne uno spazio sociale esclusivo
nel quale era possibile esprimere pienamente l’identità gaelica, ma
rappresentò anche un mezzo di rivendicazione dell’orgoglio nazionale.
All’interno di un impero inclusivo, gli scozzesi avrebbero potuto
cogliere l’opportunità di vincere i pregiudizi inglesi sul loro valore,
mettendo indiscutibilmente in mostra le qualità vantate storicamente dal
loro popolo e ristabilire la loro reputazione davanti a tutto il mondo.
Non
senza qualche residua ambiguità, l’esercito di Sua Maestà si radicò
come una delle istituzioni e delle influenze preminenti nella vita della
comunità gaelica, alla quale pure i bardi risposero positivamente.
Molti di essi prestarono difatti servizio, sotto varie circostanze e per
varie motivazioni, sperimentando la vita sui campi di battaglia e nelle
retrovie, finendo per trasferirla nei loro versi. Ciò è rispecchiato
nella predominanza dei temi militari e camerateschi, insieme a quelli
identitari, e l’opera di Kenneth Mackenzie non sfugge a questa
generalizzazione. Le Canzoni delle Highlands riflettono un mix di retaggio giacobita e lealtà al potere inglese:
Oran do dh’fhear-Chuldaothall, scritta nel 1791 in lode del capitano James Fraser di Culdothal (1756–1818) del 72° (Highland) reggimento di fanteria, a sua volta autore di versi in gaelico, acquirente di 6 copie de Orain Ghaidhealach, e futuro tenente colonnello del 2° battaglione di milizia difensiva Rothsay and Caithness.
Rann o chainnt Chaiptein Mhic-Gui’ne, dedicata al bardo Donald MacQueen di Corryburgh, che prestò servizio nella guerra americana, sposò Elizabeth Fraser nel 1792 e morì nel 1813.
Oran don Fhreiceadad dubh, in onore di Donald Fraser, il sergente addetto al reclutamento a Inverness nel 1790.
Oran do Choirneal Donnacha’ Mac’ Phearson, una delle prime odi relative alle campagne d’India, un panegirico di Duncan MacPherson (1735–1810) di Breakachy, nipote del noto giacobita Cluny MacPherson. Duncan partì per le Indie con l’89° reggimento e rientrò in Scozia nel 1766. L’opera fa riferimento al sultano del regno di Mysore, Hyder Ali (1721–1782), che appare in altri poemi del periodo come uno dei caratteristici avversari della letteratura bellica gaelica, come poi capiterà anche a Napoleone Bonaparte.
Hayder Ali è nominato anche in Oran do MhacLeoid na b Earadh, dedicata a Norman MacLeod (1754–1831), 23° capo del clan dei MacLeods, di ritorno a Londra da una missione in Oriente nel 1789. MacLeod aveva comandato il reggimento della Black Watch contro l’esercito del sultano Tipu, il primogenito di Hyder Ali.
MacLeod e il 42° reggimento della Black Watch sono il soggetto anche de Oran do na Chath-bhuithinn Rioghail Ghai’leach, questa volta in ricordo del funesto rientro in Scozia dalla guerra d’indipendenza americana. Mac Coinnich però canta di un trionfante ritorno a casa dei guerrieri delle Highlands, dei quali elenca le vittorie, comprese le precedenti battaglie della Guerra dei Sette Anni e omette la sconfitta finale, sebbene la sua presenza sui bastimenti delle rotte atlantiche, in mezzo alle voci delle ciurme che si diffondevano di porto in porto, non poteva averlo lasciato escluso dalla notizia. Ma Coinneach non associa la debacle delle armate di Sua Maestà a una sconfitta del popolo scozzese semplicemente perché il suo sguardo sulla Black Watch vede solo una forza militare esemplare e gloriosa, distintasi in battaglia come campione di una società gaelica tradizionale ed eroica, paragonabile alla leggendaria decima legione romana di Cesare. Per i suoi scopi, i soldati della Black Watch meritano di essere encomiati per aver reso al meglio onore alla memoria degli avi gaelici.
La difesa identitaria è espressa in Oran do na Caoraich-mboire, unico poema gaelico sopravvissuto dell’epoca che riprende lo stendardo dei patrioti, piuttosto che quello lealista. Il poeta dell’Inverness-shire si cimenta in un’audace denuncia sociale per la deportazione della popolazione locale che aveva servito diligentemente sia i leader scozzesi che gli interessi della Corona (le Highland Clearances, le migrazioni forzate messe in atto nella seconda metà del XVIII secolo). Coinneach Mac Coinnich beffeggia i capi clan scozzesi per essere diventati in un primo momento proprietari terrieri assenti, occupati a spendere inutilmente la loro ricchezza a Londra, e poi per aver sfrattato in massa i membri del loro stesso clan a favore delle pecore. Accusa il re Giorgio III d’Inghilterra di tirannia e di guidare la nave di stato verso il naufragio. Mackenzie attacca che la verità sta dalla parte di George Washington e che i gaeli farebbero bene a emigrare negli Stati Uniti.
Subito prima e subito dopo questa invettiva radicale appaiono canzoni come Oran do’n Earla Thuathach Triath Chlann Choinnich, che invece celebra il nobile clan Mackenzie e Moladh na Gailic, in lode sempre della sua antica stirpe; se non per rivelare comunque una posizione nostalgica. Tuirie na Gailic è un’elegia per il suo declino della reputazione del clan durante il diciottesimo secolo e Ath-leasachadh na Gàilic che sfocia in una lode al revivalismo.
Tornando a un tono più minimalistico, si possono leggere inoltre diverse liriche, o lamenti funebri, dedicati a vari conoscenti dell’autore, tra i quali alcuni che avevano pagato la sottoscrizione, ma che non sono sopravvissuti abbastanza a lungo da poterne godere. Come una sorta di ringraziamento postumo si contano Oran do Chladh Dhun-leicheidi, agus do dh’acfúinn Mhic’ Cullach, il lamento funebre per un tal MacCulloch, un allevatore di pollame di Strathairn. Il Lamento per Angus Mac Illebray, uno per William McIlbrae, per Phaidric Urachatan (Patrick Urqhuart, che ne aveva acquistate tre copie), per il capitano Shau (James Shaw, che aveva pagato pure lui per tre copie), per William Loban e un certo Brogan.
In mezzo a tutte queste elegie spuntano inaspettate un paio di satire e canti umoristici, ma anche poesie sull’amore e le donne, come Oran mar gum b’ànn le Sìom Frìosal’ Mac’ Mhtc’ Uistein, dedicata a una giovane ragazza di nome Charlotte, composta sullo stile di uno sconosciuto Simon Fraser e da cantare sulle note del motivo Over the water with Charlie.
Oppure Oran leis an Ughdair air dha bhi g’amhrac air caileagan Lunnainn
agus a smuainteachadh air caileagan an Taobh tuath,
che se fosse autenticamente autobiografica, ci racconterebbe
dell’autore durante un soggiorno a Londra, intento a osservare le
ragazze del posto mentre il pensiero correva invece a quelle del suo
Nord.
E infine alcune canzoni di carattere marinaresco che potrebbero effettivamente tradire un passato tra onde e vele: come Òran don Luing ‘s do dh’Fhear Obair a’ Chuain (Canzone per la nave e per gli uomini che lavorano in mare), che ha sottotitolato Seònaid (Janet).
[In Sar-obair, il curatore riporta, a titolo di esempio dell’arte di Coinneach, cinque componimenti del bardo di Inverness non contenuti nella raccolta Orain Ghaidhealach, tra i quali Moladh na luinge, un’ode al proprio vascello, descritto con metafore di riti femminili di passaggio, che pare sinceramente autobiografica, nel ricordo di un passato tra ponte e coperta di una nave].
E in conclusione l’esempio che riepiloga adeguatamente la vita di nonno Kenneth nella sua fase di bardo gaelico itinerante, la satira Aoire do dh’ Alastar Mac-Antoisich, su tale Alexander MacIntosh, accompagnata da una nota che avrebbe dato origine all’aneddoto riportato in Sar-obair:
Mentre l’autore stava girando per raccogliere le sottoscrizioni, arrivato a Cantry Down, all’incirca all’ora di cena, era sicuro che non gli sarebbe stato permesso di andarsene affamato, ma ben presto si rese conto che sarebbe rimasto deluso. Quando si presentò alla porta del signor M’Intosh, egli non solo gli negò la quota, ma gli intimò di andarsene immediatamente da casa sua. Certamente un cortese rifiuto sarebbe costato al nobile gentiluomo.
Nell’insieme, Canzoni delle Highlands non fornisce dettagli biografici rilevanti, ma contribuisce a un ritratto dai toni confidenziali e personali. Dal quale emerge la figura di un uomo complesso: fragile e al contempo troppo sicuro di sé; aggrappato alle proprie radici, ma sradicato. Prima la precocità nel lasciare il piccolo mondo in cui era nato per conoscere il mondo, poi, una volta lontano dalla sua terra d’origine, residente forse per un certo periodo a Londra, diventò nostalgico e le sue canzoni lo immaginavano perfettamente calato nella comunità di Inverness e Strathnairn, fianco a fianco al contadino, al maniscalco e al pastore del paese. Il titolo della sua ultima canzone però, Oran Gearan air Cairdean (Canzone di rimostranza per i parenti), dice tutto sulla realtà.
La presenza preponderante di temi marziali, il sostegno di parecchi ufficiali, la dedicatoria a un reclutatore di Inverness e specialmente la biografia scritta da John Mackenzie, farebbero immaginare che Kenneth si fosse arruolato già nei primi anni Novanta del Settecento, magari grazie al sergente Fraser e proprio in quel 78° reggimento di quel Sir Mackenzie che aveva finanziato l’Orain Ghaidhealach pagando in anticipo per sedici copie.
Ma la consultazione del materiale specialistico disponibile:
- List of the officers of the several regiments and corps of fencible cavalry and infantry: of the officers of the militia [&c.];
- A list of the officers of the Army and of the Corps of Royal Marines.
1791, 1794–1804, 1811–1819; - Army List e Monthly Army List Corrected;
- The Dublin Gazette;
smentisce
questa ricostruzione. Nel 78° Reggimento di fanteria denominato
‘Highlanders’ o ‘The Ross-shire Buffs’ costituito nel 1793, hanno
servito numerosi Mackenzie, ma nessuno battezzato Kenneth. Più in
generale nei registri del 1794 si trova un tenente Kenneth MacKenzie nel
71° reggimento di fanteria, arruolatosi nel 1783. E un altro tenente
nel 14° fanteria Bedfordshire, reclutato nel 1782. E un paio di capitani
in pensione.
Dopo la data di nascita fallace, la biografia contenuta in Sar-obair incappa
anche in questa inesattezza. Pur generalmente attendibile nel
susseguirsi degli eventi della vita di nonno Kenneth, non è di certo
infallibile nella autenticità dei dettagli.
Per individuare il nostro Kenneth bisogna fare la conoscenza di un altro poeta-soldato dell’epoca. Nel 1798 a Cork era stampata da John Cronin una delle tante antologie in gaelico:
Nuadh
Orain Ghailach, air n dianadh le Donnchadadh Chaibeull, E Sheuraemachd
Earraghaidheal; &c., Nish na shoideair Anns darna Reafmaid
Bhailla-Bhoid s’Gallaudh.
[Un Nuovo
Canzoniere Gaelico, composto da Duncan Campbell, di Argyle-shire;
&c. Ora un soldato nel 2° Battaglione Rothsay e Caithness Fencibles]
pubblicata
anch’essa grazie alle sottoscrizioni di più di 500 tra amici e
conoscenti dell’autore. In questo elenco possiamo trovare 168
commilitoni di tale 2° battaglione Rothsay and Caithness, tra i quali un
tenente K. Mackenzie.
Ora, che la nipote Marion ricordasse il nome del reggimento Kaithness, mi induce a credere di essere sulla strada giusta, ma che questo Kenneth sia colui che cerchiamo, lo suggella un reperto d’archivio conservato nella National Library of Scotland, inventario MS. 14883:
Papers, chiefly Gaelic, of Duncan Campbell, Inverness (1826–1916).
Un’ampia
raccolta di carte appartenute a Duncan Campbell, nato nella fattoria di
Kerrumore, Glenlyon, dove la sua famiglia era fittavola da tre
generazioni. Fu l’editore del Northern Chronicle, co-editore del Highland Monthly e autore di numerose opere relative alla storia delle Highlands, in particolare il Book of Garth and Fortingall.
I documenti descritti sono in molte mani diverse. I
numeri 87–89 sono stati scritti da Kenneth MacKenzie, Castle Leather,
Inverness (successivamente di Fermoy, contea di Cork), autore di Òrain Ghaidhealach, agus Bearla air an eadar-theangacha.
(87) Dan a Baird is ur làmh, prefazione del versetto. The Ochd-Shliosach,
1. Clann na Morven,
2. Edidh Ghaidheileach,
3. Cogadh na Sith,
4. Cruineacha Cath,
5. Comhraig Cath,
6. Ioman na Ruaig,
7. Clann na Gaidheil a Guailidh,
8. Deoch a’n Dorais.
Firmato da Kenneth McKenzie, Fermoy, 16 agosto. 1818.
Nota a matita: Per Donald McKenzie; James MacKenzie / 26 Castle St. / Inverness.
(88) O Eirin thuar sinn buaidh na maise.
6 quartine. Poesia in lode del duca di Wellington. In una lettera di MacKenzie al fratello (Fermoy, 20 agosto 1818).
(89) Raon na sgriosa, slios na toaibhse.
Una quartina. Il campo di Waterloo. Anche in una lettera a suo fratello Donald (Fermoy, senza data), che descrive il numero 87.
A questo punto, un Kenneth Mackenzie di Fermoy che scrive a un fratello Donald a Inverness, non può essere che il nostro Kenneth.
Nonno
Kenneth quindi, dopo essere stato un marinaio e successivamente un
poeta, ora diventava un soldato arruolato in un reggimento di Fencibles,
da defencible, difensivo, unità temporanee, milizie
composte da reclute locali e comandate da ufficiali dell’esercito
regolare, generalmente confinate in compiti di pattuglia.
Una
ricerca <2nd> + <Rothsay> + <Caithness> +
<Fencibles>, spero mi permetta di reperire qualche informazione su
quello che dovrebbe esserne stato un capitano.
Sir John Sinclair, rampollo dei Sinclair dell’Ulster era uno statistico, un riformatore agrario e un parlamentare, ma quando ricevette una lettera di servizio direttamente dal Primo Ministro inglese William Pitt, nella quale gli chiedeva di sostenere direttamente la causa lealista, si calò nella parte di capo guerriero e formò sotto i suoi ordini un primo battaglione di milizie battezzato Rothsay and Caithness Fencibles. Nel dicembre 1794 gli arrivò l’ordine di istituire anche un secondo battaglione; il tenente generale Hamilton, responsabile dell’arruolamento, terminò di compilare la lista di 600 uomini previsti nel maggio del 1795 e così solo nell’edizione de The Dublin Gazette, numero 6181, dei primi di Giugno, è riportato che Kenneth era stato inquadrato come uno degli alfieri del battaglione, all’epoca il più basso rango di sottoufficiale in servizio nei reggimenti di fanteria dell’esercito britannico.
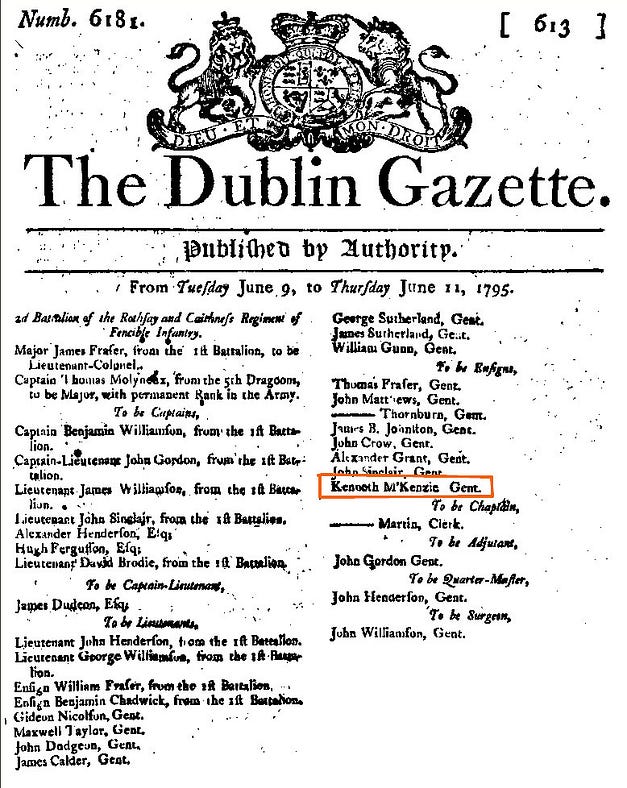 |
| Kenneth Mackenzie, alfiere del 2° battaglione Rothsay & Caithness Fencible nel 1795 |
Il
battaglione fu subito spedito in Irlanda, per pattugliare i centri
urbani contro i venti sediziosi che soffiavano dalle parti di Dublino.
Stazionò per poco più di un anno nell’Ulster, soprattutto ad Armagh,
fino a metà del 1796. Quindi trasferito nel sud dell’isola, nella contea
di Cork.
Kenneth Mackenzie sparisce dai registri ufficiali del 1797 e
1798, per riaffacciarsi come tenente il 1 marzo 1799. In quell’anno
però, cessata l’emergenza rivoluzionaria, tutti i battaglioni di milizia
difensiva furono sciolti per regio decreto.
Sir Sinclair e i gradi
superiori dell’esercito reale valutarono che fosse un peccato perdere
quelle unità di eccellenza che tanto si erano distinte durante il loro
servizio. Fu deciso così che si dovesse formare, al posto dei due
battaglioni, un nuovo reggimento di fanteria regolarmente annoverato tra
le forze di Sua Maestà, chiamato Caithness Highlander.
Mackenzie
scelse di rimanere, come molti altri camerati dei due battaglioni
Rothsay and Caithness. Nel 1801 venne anche promosso, raggiungendo il
grado di tenente capitano.
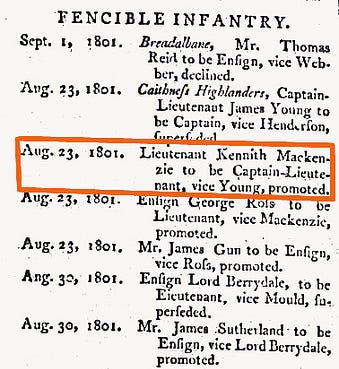 |
| Kenneth Mackenzie, tenente dei Caithness Highlanders nel 1801 |
Per poco però, visto che nel 1802 il battaglione fu definitivamente smembrato.
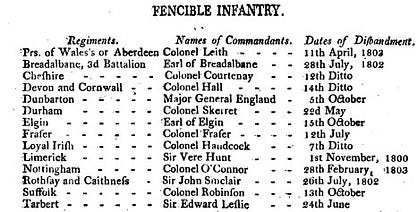
E sembra anche la fine della carriera militare di Kenneth. In A List of All the Officers of Army and Royal Marines on Full and Half-pay… del 1805, tra gli ufficiali messi a mezza paga, dall’anno 1800, compare per la prima volta in pensione:
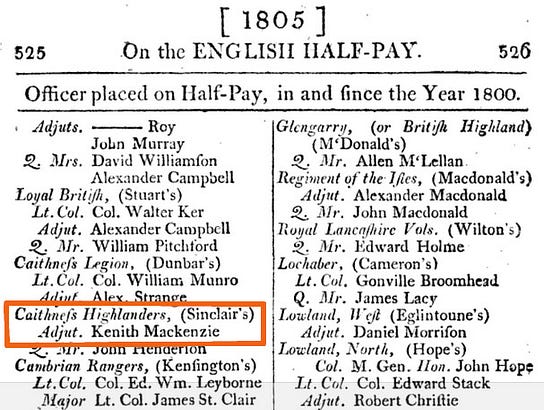
E lo si ritrova in tutte le edizioni seguenti fino al 1819.
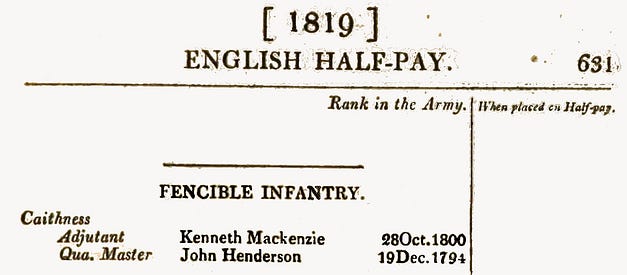
Anche se la data di arruolamento, 28 ottobre 1800, non collima affatto con le informazioni precedenti che lo vedono in divisa almeno dal 1795. Sarebbe da approfondire se il periodo di servizio come milizia fosse escluso dalla pensione militare. Potrebbe essere che a Mackenzie abbiano conteggiato solo la leva sostenuta a partire da quando i due battaglioni Rothsay and Caithness sono diventati il reggimento Caithness Highlanders, regolarmente inquadrato nell’esercito di Sua Maestà.
A parte l’età — Mackenzie si arruolò a trentatre/trentaquattro anni, al congedo ne aveva quaranta/quarantuno, il limite era quarantacinque — il motivo che quasi sicuramente lo spinse ad abbandonare la carriera militare e a fermarsi in Irlanda, lo scopro in un altro determinante documento d’archivio:
The National Archives of the UK; Kew, Surrey, England; War Office: Officers’ Birth Certificates, Wills and Personal Papers.
BRITISH OFFICERS AND THEIR FAMILIES; Class: WO 42; Piece: 030; Piece Description: Piece 030: M. 147–298 (1776–1881).
Richiesta di pensione come vedova di un ufficiale a mezza paga
Maria Mc Kenzie si è presentata oggi dinanzi a me e ha prestato giuramento di essersi legalmente sposata il 2° giorno di Febbraio del 1799 con Kenneth Mc Kenzie, ex Tenente Capitano e aiutante di campo a mezza paga del Caithness Highlander, reggimento di fanteria, che è deceduto a Fermoy il 20 Gennaio 1819 e che ella non percepisce già alcun tipo di pensione, indennità o provvigione governativa.
Giurato davanti a me a Fermoy
lì 3 Marzo 1819
Thomas Powell
Il buon Kenneth aveva una nuova famiglia. Dopo quattro decenni di vita avventurosa, possibile fosse arrivato il momento di stabilirsi. L’amicizia dei compagni d’armi magari non bastava, oppure il colpo di fulmine non gli lasciò scampo. Giustamente l’amministrazione militare, per erogare la pensione di reversibilità richiedeva la documentazione attestante i requisiti. Ecco allora che allegato alla domanda trovo il certificato di matrimonio.
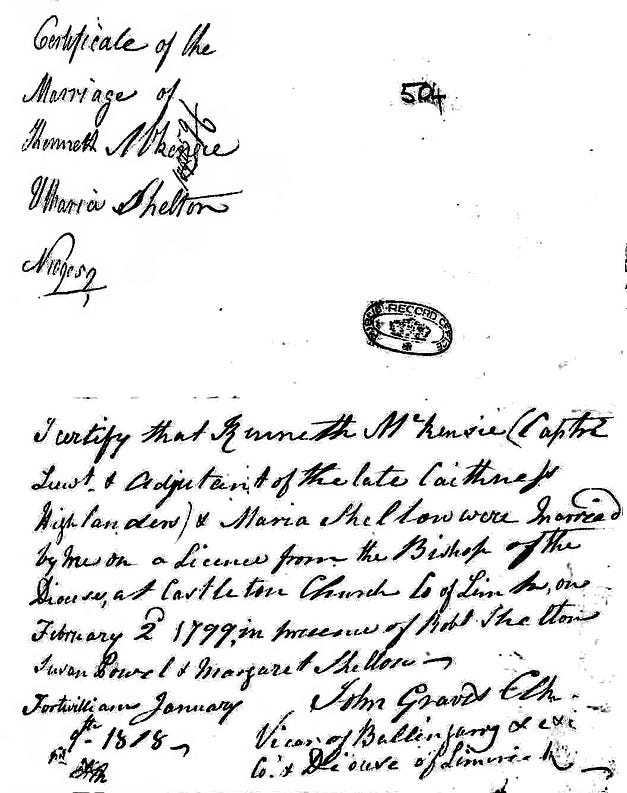
Certifico che Kenneth McKenzie (tenente capitano ed aiutante degli ex Caithness Highlanders) & Maria Shelton sono stati sposati da me, su licenza del vescovo della diocesi, nella chiesa di Castleton della contea di Limerick, il 2 febbraio 1799, in presenza di Robert Shelton, Susan Powel & Margaret Shelton.
John Graves,
Vicario della chiesa di Ballingarry e della diocesi di Limerick
Fort-William,
9 gennaio 1818.
Che il Vicario di Ballingarry abbia certificato il vero, lo conferma l’annuncio apparso sul quotidiano Saunders’s News-Letter del 18 Febbraio 1799:
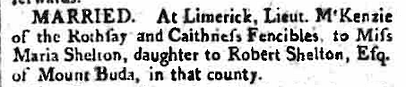
E ripreso identico sia in Aberdeen Press and Journal che in Walker’s Hibernian Magazine di Marzo.
Come
molti altri commilitoni dei corpi delle Highlands, sotto le armi
Kenneth aveva condotto una vita parca e rigorosa. Risparmiando su tutto.
Vestiva esclusivamente con le uniformi, stivali e qualunque altro
corredo forniti dall’esercito, mangiava solo il rancio quotidiano, del
quale a volte se ne privava pure, per rivendere la razione a qualche
irlandese e ottenere un’entrata extra. Non frequentava taverne e
locande, né pagava per avere una donna. Gli ufficiali erano a conoscenza
di questa pratica eccessivamente virtuosa che poteva pericolosamente
sfociare in una generale malnutrizione e deperimento delle truppe, e
tentavano invano di prevenirla. Il soldato Mackenzie a ogni modo
perseverò e accantonò di mese in mese quanto più possibile della sua
paga, così che al congedo aveva accumulato un piccolo capitale di oltre
100£, equivalente a qualcosa più che un paio d’anni di salario di un
onesto artigiano.
A tre anni dal matrimonio, durante i quali continuò
a servire nell’esercito, si sistemò con la moglie Maria a Killmeedy,
nella contea di Limerick. Dove nacquero i primi tre figli.
- Maria, il 26 Luglio 1804
- John Campbell, l’11 Agosto 1805
- Robert Shelton, il 9 Luglio 1806
In questo intervallo di tempo non ho alcuna idea di come occupasse il suo tempo, se il fuoco della poesia fosse ancora acceso, se mantenesse in qualche modo la famiglia o se magari proprio la mancanza di un impiego, la mezza paga dell’esercito era sicuramente inadeguata a mantenere tre figli e un quarto in arrivo, lo convinse ad accettare agli inizi del 1809, il posto di direttore dell’ufficio postale di Fermoy nella contigua contea di Cork. Qui ebbero i natali i successivi quattro figli della coppia.
- Rowland Hill, il 2 Febbraio 1809
- Isabella, il 14 Aprile 1811
- Eliza Jane, il 21 Novembre 1817
- Susannah, il 29 Luglio 1819
Anche se non è nemmeno citato il suo nome, un’avventura della quale è facile riconoscere nel protagonista il bardo Coinneach Mac Coinnich descritto da John Mackenzie, è riportata in William Joseph O’Neil Daunt, Personal Recollections of Daniel O’Connell, Volume 1, Londra: Chapman and Halls, 1848:
L’ultimo
brigante che minacciava la strada che attraversano le montagne di
Kilworth fu ucciso nel 1810 circa dal direttore di posta di Fermoy.
Negli ultimi tempi diverse persone erano state costrette a rendere
omaggio a questo esattore abusivo della strada reale, così il direttore
dell’ufficio postale, insieme a un altro cittadino di Fermoy, noleggiò
una carrozza e la guidò sulle montagne di Kilworth. Il ladro notò la
carrozza, la spiò mentre si avvicinava e al momento che ritenne più
opportuno si lanciò sulla sua preda e diede il consueto ordine «O la
borsa o la vita!» La risposta del direttore delle poste lo colse
alquanto di sorpresa, poiché quell’ufficiale combattivo gli sparò a
morte incontinentemente.
Tutta questa prestanza però non gli bastò, ben prima della nascita dell’ultima figlia Susannah, il 20 febbraio 1819, dopo qualche settimana di malattia, Kenneth morì.
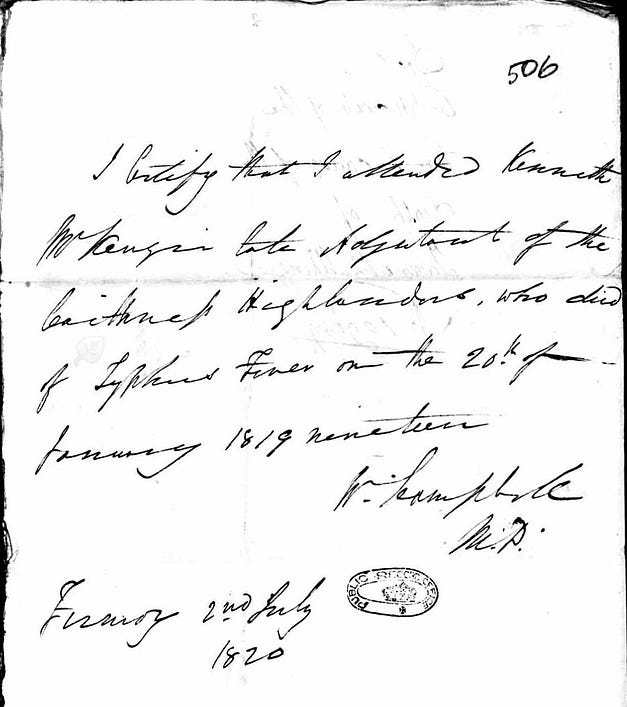
Io certifico di aver assistito Kenneth Mackenzie, ex aiutante dei Caithness Highlanders, il quale è deceduto per la febbre tifoide il 20 gennaio 1819 diciannove.
W. Seampbole (?) M.D.
Fermoy, 2 Luglio 1820
Annunciato così dal Cork Morning Intelligencer:
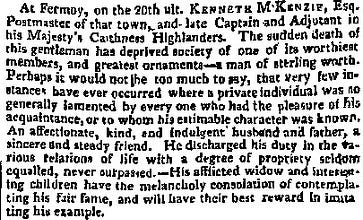
A
Fermoy, il 20 dell’ultimo mese, Kenneth M’Kenzie, Esq. direttore delle
Poste di quella cittadina, e precedentemente Capitano e Aiutante nei
Caithness Highlanders di Sua Maestà. La morte improvvisa di questo
gentiluomo ha privato la società di uno dei suoi più meritevoli membri, e
grande orgoglio — un uomo assolutamente eccellente. Forse non sarebbe
troppo dire che sono veramente pochi i casi occorsi, nei quali una
personalità privata fu così generalmente compianta da chiunque avesse
avuto il piacere di conoscerla, o della quale l’inestimabile carattere
era comunemente riconosciuto. Un affettuoso, gentile e indulgente marito
e padre, un amico sincero e sicuro. Ha assolto i suoi doveri nella
varie relazioni della sua vita con un grado di dignità raramente
eguagliato, sicuramente mai superato. — La sua afflitta vedova e i suoi
interessanti figli hanno la malinconica consolazione di poter
contemplare la sua discreta fama, e di avere la loro migliore ricompensa
nell’imitare il suo esempio.
Ricordato anche in patria da The Inverness Courier, in forma più sintetica, ma aggiungendo in conclusione un dettaglio saliente per la sua biografia in definizione:
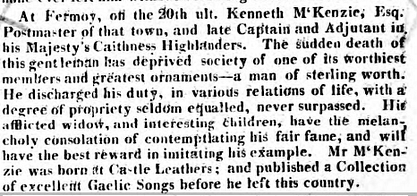
(…) Il signor M’Kenzie nacque a Castle Leathers; e pubblicò una collezione di eccellenti canzoni gaeliche prima di lasciare questa terra [la Scozia].
Insomma,
finisce così l’esistenza di quest’uomo, in un momento apparentemente
tranquillo, almeno rispetto al passato. Del quale a questo punto è
possibile delineare una biografia, sicuramente non ancora definitiva, ma
sostenuta almeno da alcuni punti fissi.Coinneach
Mac Coinnich nacque a Castle Leathers nel 1762, dal fittavolo Kenneth
Mackenzie e da Isabel Denoon. Trascorse l’infanzia, terzo di sette
fratelli e sorelle, tra il paese natale e Culduthel, spostandosi a
seconda che il capofamiglia dovesse gestire le terre in un luogo e
nell’altro. Forse Coinneach non fu particolarmente felice, magari era
solo molto curioso, oppure un po’ ribelle, poiché appena possibile, avrà
avuto diciassette o diciotto anni, lasciò casa per andarsene il più
lontano possibile. Forse nella Marina Reale, forse più probabilmente a
bordo di bastimenti commerciali, si imbarcò come equipaggio. Il suo
peregrinare durò quasi dieci anni, fece rientro a casa prima del 1792.
Forse un anno, forse più, tenendo conto che si girò mezza Scozia a piedi
per raccogliere i fondi per pubblicare a proprie spese il suo
canzoniere.
Come a voler mettere in pratica gli ideali della sua poetica, vestì l’uniforme imperiale, contribuendo a sedare per conto di Giorgio III, re di Gran Bretagna e d’Irlanda, nelle file del 2° battaglione Rothsay e Caithness, la rivolta irlandese del 1798. Giusto il tempo di raggiungere il grado di ufficiale e si ritirò nel 1802. Intanto nel 1799, a trentasette anni, si era sposato con l’irlandese Maria Shelton, di nobile famiglia. In Irlanda avrebbe messo radici. Si spostarono da Drews Court a Kilmeedy e infine a Fermoy, da dove non si sarebbero più mossi. Attesero il suo congedo definitivo e diedero al mondo sette figli in quindici anni. Nell’ultimo capitolo della sua vita svolse il proprio dovere in un piccolo e pacifico ufficio postale di provincia, rispettato e benvoluto dalla sua comunità adottiva, prossimo a godersi la pensione in una casa piena di vita. Oltre alla numerosa prole, la dimora era ritrovo di ospiti abituali e occasionali. Un’accoglienza particolare era rivolta soprattutto ai connazionali scozzesi di passaggio sulle rive del fiume Blackwater. Talmente ospitale che Ronald Black nel suo An Lasair, forse sovrainterpretando quelle espressioni come “le abitudini di un uomo di mare hanno un’influenza deteriorante sui sentimenti giovanili” e “accarezzare letteralmente i suoi compatrioti” vergate in Sar-obair, arriva a sostenere che John Mackenzie non poteva alludere più esplicitamente alla possibile omosessualità di Kenneth. Tutto apparentemente idilliaco.
Tutto
però finì dopo la stagione delle piogge del 1816, quando un’epidemia di
febbre iniziò a colpire l’Irlanda. Una terra costantemente infestata da
questa malattia, afflitta da scarsità e cattiva qualità delle
provviste; da aumento dei fallimenti nel commercio dovuti alla recente
fine della guerra e conseguentemente di bisognosi che affollavano i
centri urbani alla ricerca di lavoro. Quella che materialmente non
differiva da una comune febbre, iniziò ad accompagnarsi a una
prosciugante diarrea e a colpire un numero incrementale di irlandesi. Ma
soprattutto cominciava a mostrare un’alta percentuale di ricaduta.
Senza difformità tra le varie contee, principalmente tra le classi
inferiori, ma non del tutto limitata a queste, visitando occasionalmente
anche individui in migliori circostanze.
In uno sfortunato giorno di
fine 1818, l’epidemia colpì anche la famiglia Mackenzie. Nonna Maria e
tre dei figli patirono un attacco severo di febbre, ma sopravvissero, e
quando dopo oltre un mese si stavano finalmente ristabilendo, un bacillo
di Salmonella Choleraesuis infettò l’organismo di Kenneth.
Oramai
sapevano come procedere. Kenneth fu separato dai familiari, venne
spostato in una stanza isolata della casa. Il pagliericcio del letto
veniva bruciato e cambiato ogni mattina, le finestre spalancate per
cambiare l’aria, i vestiti e la biancheria stesi al sole.
La
manifestazione della malattia fu graduale: la febbre salì
progressivamente, arrivarono il mal di testa, la mancanza di appetito e
il dolore addominale. Non riusciva più a stare seduto, la sua schiena
scivolava inesorabilmente lungo il letto, costringendolo a passare la
maggior parte del tempo disteso. Dopo due settimane di febbre alta
nonostante i bagni in acqua fredda, l’inevitabile deperimento, l’aspetto
particolarmente secco e sporco della pelle e l’odore caratteristico dei
malati, cominciò ad accusare disordini a carico del sistema nervoso.
Episodi di delirio, di perdita di memoria e disturbi dell’udito. I suoi
occhi presentavano un aspetto particolarmente pesante e languido. La sua
voce, alterata fin dall’inizio, era diventata gutturale, quasi
sepolcrale. Quando fu colpito da stupor, fu chiaro che la prognosi era
infausta.
Bibliografia.
A cura di Stephen W. Brown, Warren McDougall, The Edinburgh History of the Book in Scotland, Volume 2, Enlightenment and Expansion, 1707–1800, Edinburgh University Press, 2012.
A cura di Ian Brown, Thomas Owen Clancy, Susan Manning and Murray Pittock, The Edinburgh History of Scottish Literature, Volume Two: Enlightenment, Britain and Empire (1707–1918), Edinburgh University Press, 2007.
Matthew P. Dziennik, The Fatal Land: War, Empire, and the Highland Soldier in British America, Yale University Press, 2015.
Niall Ó Ciosáin, Popular Song, Readers and Language: Printed Anthologies in Irish and Scottish Garlic, 1780–1820, in John Kirk, Cultures of Radicalism in Britain and Ireland, Londra: Routledge, 2013.
Ruairidh Iain Maciver, The Gaelic Poet and the British military
experience, 1756–1856. Tesi presentata all’Università di Glasgow, per la laurea in filosofia, nel 2018.
Ronald Black, An Lasair: Anthology of 18th Century Scottish Gaelic Verse, Edinburgh: Birlinn, 2001.
Ronald Black, The Ear of the Beholder: John Mackenzie of The Beauties, in Scottish Studies, vol. 39, Università di Edimburgo, 2022.
John Kirk, United States? The Languages of Resistance, Routledge, 2015.
Commenti
Posta un commento